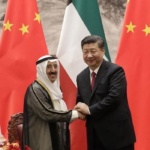Così la Cina fa shopping in Africa. Tra il silenzio (colpevole) di Obama
Si sposta il baricentro energetico del pianeta dai paesi arabi alla Russia, divenuta il maggior esportatore di energia al mondo grazie all’accordo con la Cina che sta comprando le risorse africane, inserendosi in settori fino ad oggi dominati dall’Occidente.
E’ evidente che in questi giorni stia avvenendo un cambio epocale nei rapporti tra nazioni ed economie: il baricentro energetico del pianeta si sta spostando dai paesi arabi alla Russia, divenuta solo pochi giorni fa il maggiore esportatore di energia al mondo grazie all’accordo da 70 milioni di dollari con la Cina, aggiuntasi ai clienti di Putin dopo l’Europa e gli Stati Uniti. Mentre si profila un probabile declino dello strapotere arabo sul mercato del petrolio, si è configurata una nuova inedita alleanza tra superpotenze, un tempo avversarie nella Guerra Fredda ed oggi in una fase di cooperazione all’insegna del “volemose bene”. Naturalmente tutto questo ha un costo: tutti i membri di questa potentissima triade hanno dovuto mediare, moderare alcune proprie posizioni anche di ordine etico.
La Cina in particolare è la nazione che più delle altre due solleva il malessere non solo dei mercati, delle organizzazioni sopranazionali, dell’opinione pubblica ma anche delle associazioni per i diritti umani. Mentre per i Russi la spregiudicatezza cinese non impone alcun dilemma morale, per gli americani qualche problema c’è, ma il pragmatismo di Obama ha consentito di “dimenticare” velocemente la questione tibetana (evitando di incontrare il Dalai Lama a Washington) e di assistere senza commento al saccheggio delle materie prime africane da parte di Pechino.
La Cina sta comprando le risorse africane e sta inserendosi in settori fino ad oggi dominati dall’Occidente penetrando quel mercato con metodi perlomeno discutibili. La dirompente rivoluzione industriale cinese si fonda sulla disponibilità di minerali africani e trova spazio sul mercato africano sotto forma di radio, telefoni e batterie a basso costo e di bassa qualità. Di 100 t-shirt vendute in Sud Africa 80 sono cinesi, ma questo ha significato ammazzare l’industria tessile sudafricana e la perdita di posti di lavoro locali.
Durante la presidenza Bush l’interscambio tra Africa e Cina è cresciuto di dieci volte, da 10 miliardi di dollari a 107 miliardi nel 2008, finendo per garantire la sopravvivenza anche a regimi internazionalmente esecrati come quelli del Sudan e dello Zimbabwe. Per esempio la cinese Exim Bank, la terza più grande agenzia di credito al mondo, è divenuta per i regimi più illiberali l’appetibile alternativa alla Banca Mondiale, un partner finanziario più solerte e soprattutto meno schizzinoso in materia di diritti civili e umani.
L’amministrazione Obama ha espresso il desiderio di ravvivare le attività americane in particolare in paesi avviati verso la democratizzazione come il Ghana, particolarmente nel settore agricolo, secondo molti economisti il comparto in maggiore crescita in Africa nei prossimi decenni. Ma, aldilà di agricoltura, salute e aiuti umanitari, gli Stati Uniti, ma anche l’Occidente, restano a margine mentre le banche cinesi prestano denaro per pagare le aziende cinesi che costruiscono l’Africa. La Cina torna in Africa nel 21mo secolo non solo alla ricerca di risorse per lei vitali ma senza i freni etici che hanno allontanato per esempio le ditte americane e occidentali dal mercato del petrolio sudanese, rapidamente divenuto monopolio cinese.
L’Africa rimane suo malgrado terreno di scontri più o meno occulti tra potenze esattamente come lo fu negli anni della Guerra Fredda, con la Cina che in definitiva gioca il ruolo che fu a suo tempo dell’Unione Sovietica. Nel gioco a tre per la spartizione delle risorse planetarie anche la Cina però ha dovuto cedere qualcosa, ad esempio forzando a più miti consigli l’alleato nord coreano, obbligandolo più volte a moderare i toni anti-americani e soprattutto ha dovuto soprassedere sulle pretese territoriali della regione dell’Ussuri, contesa all’Unione Sovietica ed ora addirittura teatro di esercitazioni congiunte tra esercito russo e cinese, su quelli che a fine anni ’60 furono i campi di battaglia dove quelle truppe si scontrarono.
Chi ha tutto da guadagnare invece è la Russia, che ha finito di spendere cifre insostenibili per le proprie spese militari optando per la più efficace arma del controllo delle forniture energetiche. Oggi l’Europa dipende dal gas russo e da poco anche USA e Cina dipendono dal petrolio russo. Domani l’Iran dipenderà dall’uranio arricchito in Russia (se il piano messo a punto dall’IAEA per il nucleare iraniano andrà finalmente in porto) collocando la risorta potenza in una posizione semi-monopolistica nel settore dell’energia, e quindi dotandola di uno straordinario, ma anche preoccupante nuovo potere.
Fonte: Affari Italiani, 2 novembre 2009
Articoli correlati:
Condividi:
 Stampa questo articolo
Stampa questo articolo
| Condizioni di utilizzo - Terms of use |
|---|
| Potete liberamente stampare e far circolare tutti gli articoli pubblicati su LAOGAI RESEARCH FOUNDATION, ma per favore citate la fonte. |
| Feel free to copy and share all article on LAOGAI RESEARCH FOUNDATION, but please quote the source. |
 Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale 3.0 Internazionale. |